Mario Schifano
ARTISTI > Mario Schifano
biografia
Mario Schifano (Homs 1934 – Roma 1998), insieme agli altri artisti di Piazza del Popolo a Roma come Franco Angeli e Tano Festa, ha rappresentato un momento fondamentale della Pop Art italiana ed europea. Onnivoro di immagini –coerente con il clima internazionale degli anni Sessanta e Settanta– ha oltrepassato le barriere della pittura e delle arti visive, sconfinando nella sperimentazione cinematografica.
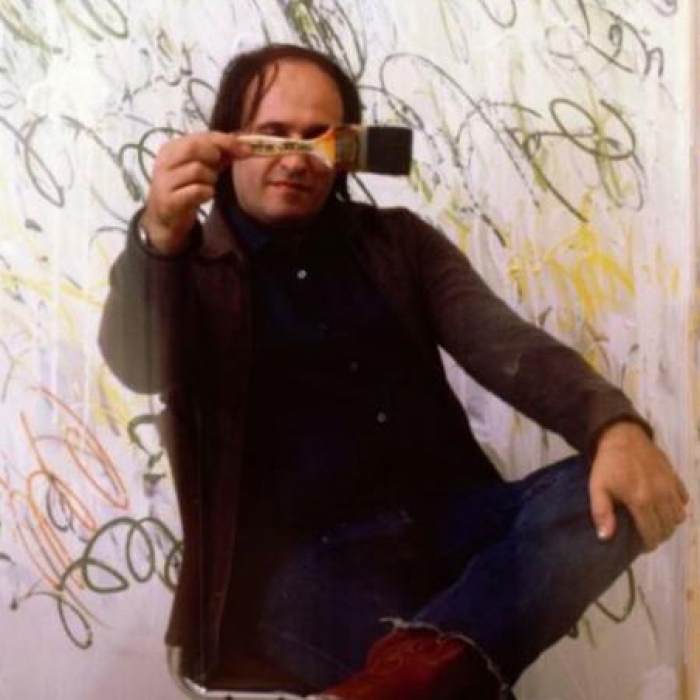
Mario Schifano (Homs 1934 – Roma 1998), insieme agli altri artisti di Piazza del Popolo a Roma come Franco Angeli e Tano Festa, ha rappresentato un momento fondamentale della Pop Art italiana ed europea. Onnivoro di immagini –coerente con il clima internazionale degli anni Sessanta e Settanta– ha oltrepassato le barriere della pittura e delle arti visive, sconfinando nella sperimentazione cinematografica.
Mario Schifano > opere

100 x 130 cm
1992
Cod. 197

51 x 73 cm
1990
Cod. 167

51 x 73 cm
1990
Cod. 153

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 152

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 149

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 148

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 147

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 146

10x15 cm
anni '90
Cod. 144

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 142

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 141

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 140

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 139

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 138

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 137

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 135

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 134

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 133

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 131

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 130

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 129

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 128

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 126

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 125

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 124

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 122

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 121

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 120

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 118

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 117

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 116

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 112

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 111

10x15 cm
anni '90
Cod. 109

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 108

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 107

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 106

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 105

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 104

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 103

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 102

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 100

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 99

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 97

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 96

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 95

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 92

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 91

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 89

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 85

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 84

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 79

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 78

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 76

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 74

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 72

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 70

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 69

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 67

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 66

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 65

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 63

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 62

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 61

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 60

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 58

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 57

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 56

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 54

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 52

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 51

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 49

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 48

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 47

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 46

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 45

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 44

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 43

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 42

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 41

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 40

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 36

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 34

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 32

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 31

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 29

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 28

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 27

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 26

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 22

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 21

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 20

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 19

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 18

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 17

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 15

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 11

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 9

10x15 cm
anni '90
Cod. 8

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 4

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 1

100 x 130 cm
1992
Cod. 197

51 x 73 cm
1990
Cod. 167

51 x 73 cm
1990
Cod. 153

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 152

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 149

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 148

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 147

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 146

10x15 cm
anni '90
Cod. 144

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 142

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 141

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 140

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 139

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 138

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 137

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 135

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 134

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 133

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 131

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 130

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 129

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 128

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 126

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 125

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 124

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 122

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 121

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 120

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 118

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 117

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 116

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 112

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 111

10x15 cm
anni '90
Cod. 109

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 108

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 107

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 106

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 105

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 104

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 103

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 102

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 100

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 99

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 97

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 96

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 95

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 92

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 91

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 89

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 85

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 84

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 79

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 78

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 76

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 74

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 72

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 70

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 69

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 67

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 66

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 65

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 63

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 62

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 61

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 60

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 58

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 57

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 56

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 54

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 52

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 51

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 49

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 48

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 47

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 46

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 45

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 44

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 43

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 42

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 41

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 40

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 36

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 34

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 32

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 31

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 29

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 28

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 27

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 26

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 22

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 21

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 20

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 19

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 18

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 17

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 15

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 11

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 9

10x15 cm
anni '90
Cod. 8

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 4

10 x 15 cm
anni '90
Cod. 1
Mario Schifano > mostre
2x10 Dieci artisti per vent'anni di BOXART
Galleria Boxart, Verona
Omaggio a Mario Schifano
Sala Austriaca, Castel San Zeno, Montagnana (PD)
Mario Schifano. Doppio sguardo
I vizi capitali
Galleria Boxart, Verona
Istantanea di Mario Schifano
Galleria Boxart, Verona
Il pianeta delle immagini "dinosaure"
Galleria Boxart, Verona
Mario Schifano > cataloghi

HUMAN
Dimensioni 25 x 18,5 cm
Mario Schifano. Doppio sguardo
Achille Bonito OlivaDimensioni 33,5 x 24,5 cm




